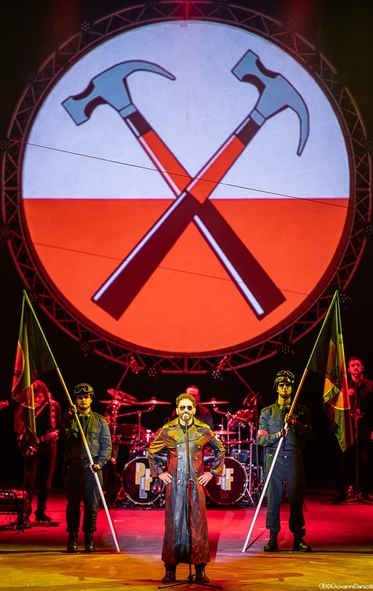Il 21 novembre, al Teatro Off-limits di Avezzano presso il Castello Orsini, è andato in scena Depravazione – A proposito della neve bagnata, coraggioso rifacimento della seconda parte di Memorie dal sottosuolo di Fëdor M. Dostoevskij (1864).
L'allestimento vede il debutto in campo teatrale di Stefano Colucci, giovane poeta, regista e sceneggiatore noto nel panorama queer per i suoi cortometraggi (Summertime mon amour, 2020; By Sex, 2025) e per la direzione del festival cinematografico Queer Days. In conversazione con noi al termine dello spettacolo, afferma che, dal suo punto di vista, la depravazione violenta è una condizione inconscia appartenente a tutti. La sua missione registica è decostruire la figura maschile incapace di rapportarsi col femminile, e oggi lo fa attraverso il corpo dell'unico interprete in scena: Luca Avallone.
Già Cinzia TH Torrini, nella miniserie Un'altra vita (2016), aveva costruito su Avallone un eroe totalmente negativo, esclusivamente sadico: per il gusto della profanazione, il suo personaggio seduceva e abbandonava incinta un'innocente.
Nell'horror Le grida del silenzio (di Alessandra S. Carlesi, 2018), l'attore riproponeva il rifiuto violento di legarsi a una donna, collegandolo all'incapacità di sentirsi vivo. Con pulsione sia sadica sia masochista, cercava una morte purificatrice per poi scoprire di essere già morto da decenni. La ricerca avveniva confrontandosi in particolare con due attraenti ragazzi con cui instaurava rapporti omoerotici sottolineati dal classico leitmotiv dello scambio di sigaretta.
L'attore iniziava qui ad abbracciare il mondo del New Queer Cinema e a completare la figura di maschio nevrotico e allucinato, che si rivela castrato dalla sua stessa femminilità: ritratto che calzerà totalmente con il protagonista di Memorie dal sottosuolo.
.jpg)
Sempre nel 2018, Avallone faceva da volto pubblicitario a Love, Simon (di Greg Berlanti), film che ha segnato un epocale cambiamento di paradigma: dal New Queer Cinema al mainstream queer. Il primo è provocatorio, violento e sovversivo, incline al citazionismo schizofrenico e all'Assurdo, ambiguo e contraddittorio; il secondo presenta alti livelli produttivi e distributivi e finali in cui le componenti sociali non eterosessuali si danno per felicemente accettate dalla società: sono film in cui non si deve più morire né soffrire né essere ridicoli per essere protagonisti omosessuali.
Nello stesso anno, con la pièce Invisibile, Avallone dirige una sceneggiatura di Colucci in un contesto teatrale iscritto totalmente nel New Queer, e non nel mainstream, affrontando temi come suicidio lesbico e allucinazione post-bullismo.
Più recentemente, in Emanuelle – Do ut des (di Dario Germani e Monica Carpanese, 2023), erotico d'autore che esplora molteplici sfumature del BDSM, Avallone torna totalmente sadico, libero di espandere autorialmente il suo personaggio che costruisce la trappola perversa. L'attore ci conferma che, proprio perché non riconosce se stesso come “il mostro” di tutta la narrazione, gioca e scherza con la morte, esattamente come oggi con Veronique (nome d'attrice dato al busto-manichino che interpreta Liza in Depravazione), con la quale ha il giocoso accordo di spararle un solo colpo a sera anche se poi finisce per scaricarle un intero tamburo di proiettili addosso.
Avallone si è diplomato con il massimo dei voti presso l'Accademia d'Arte Drammatica “P. Scharoff”, e questo è palese dalla dizione impeccabile, dal sublime virtuosismo vocale e corporeo e dal fortissimo uso ironico che lui fa del mimo.
Rispetto alla carriera teatrale portata avanti con successo con il Coriolano di Shakespeare (2014-22), da eroe percepito, secondo Avallone, come positivo per la sua fisicità di «soggetto puerile, infantile, puro» – la dostoevskiana Depravazione è, secondo l'attore, una novità che può essere interpretata come prosecuzione e massima amplificazione dei suoi personaggi cinematografici sopra citati.
Lo spettacolo, infatti, nel suo stile assurdo, sanguinario e apocalittico, si avvicina, come confermano i due autori-attori, al New Queer Cinema che Avallone aveva già portato sullo schermo e per questo va letto anche in prospettiva di quel cinema.
Il regista Colucci ci avverte che l'uso delle luci rosse e blu (che rendono visivamente lo stato allucinatorio che il testo affidata alla metafora della neve), del costume alla Dale Cooper e del busto-statua in stile Twin Peaks stanno a marcare che la doppiezza del protagonista è volutamente lasciata sospesa all'interpretazione del pubblico.
.jpg)
Infatti, come in David Lynch, l'ossessione per la carne femminile squartata è sadica e spettacolarizzata con gusto: non è detto che la pulsione sadica nel finale sia redenta o pentita. Ciò perché non è affidabile, come dice Freud, alcun messaggio di Dostoevskij.
Si tratta piuttosto di una pluralità magmatica di voci e significati, tutti validi, in contraddizione dissonante tra loro: questo non è solo tipico del Postmoderno, di Lynch e di P. P. Pasolini (citato dalla maschera da maiale ripresa dalla nuova locandina del film Porcile e dal finale assimilabile alla pièce Orgia) ma è, nel massimo studio dedicato da M. Bachtin all'autore russo, Poetica e stilistica di Dostoevskij (1929) polifonica, carnevalesca carrellata di voci in contraddizione persino quando, come in Memorie dal sottosuolo, si tratta di un monologo che è una confessione drammatizzata.
È Avallone stesso a dirci che non si tratta soltanto di una o di tre voci: per questo, lui, come attore e coautore, non può assumersi la responsabilità del Male che ne esce e subisce un'attrazione-identificazione soltanto con il destrutturato e distrutto personaggio del finale.
Ma come spiega Massimo Fusillo (1989), l'identificazione col Male procede per diniego feticista: nella nostra «civiltà della vergogna», si può godere del proibito solo negandolo, dicendo: «non sono io».
Per questo, l'autoderisione che il personaggio compie è necessaria per ottenere l'identificazione sadica del pubblico e dell'attore, soprattutto in un'opera in cui così tante volte ricorre la parola «vergogna».
Proprio come Paolo Nori (2021), che leggendo una precisa frase di Memorie dal sottosuolo subì un plagio emotivo come se Dostoevskij gli avesse rubato l'identificazione, anche Avallone inizia lo spettacolo pronunciando quella stessa frase, che è la fonte di tutte le emozioni negative del dramma: «Io sono uno e loro sono tutti».
Tale posizionamento rabbioso è dominante sia nel testo originario sia nello spettacolo. Perciò Colucci, citando Lynch, ci ricorda che non si deve e non si può mai sventolare un messaggio finale didascalico: sono gli spettatori a essere direttamente interpellati (come nel testo fa Dostoevskij col «voi») e a essere essi stessi coautori dell'opera aperta.
È un'opera soprattutto circolare. La presenza di Liza è anticipata: perciò l'ultima parte del romanzo è distribuita a più riprese lungo tutta la pièce. Sono eliminati i personaggi degli amici e del servo Apollon: tutto è solo discorso frantumato che non distingue lo spaziotempo del prima (la sequenza delle frustrazioni che hanno fatto accumulare la rabbia nel protagonista) dallo spaziotempo del dopo (la punizione inferta all'innocente Liza).
Infatti, come è tipico del New Queer Cinema, che i coautori prendono a modello, il tempo e lo spazio sono assolutamente mentali, frammentarie eterotopie solipsistiche in disconnessione: tutto accade nel sottosuolo in un andirivieni circolare di parole e canzoni di Ciampi ed Elvis in quello che è non una costruzione causale lineare ma uno spettacolo di performance parlata, mimata e danzata dove Avallone «anguilleggia» istericamente.
Come rileva Ilaria A. De Pascalis (2015), per alcune narrazioni del contemporaneo dedicate alle soggettività metamorfiche e queer, la narrazione è tipicamente autobiografica, irreale e rizomatica e assume un punto di vista femminilizzato sulle dinamiche traumatiche dell'esperienza della violenza nei regimi dell'ironia e dell'Assurdo. Come è tipicamente rilevato nelle contemporanee narrazioni sul trauma, sempre autobiografiche, inaffidabili e contraddittorie, i soggetti e gli accadedimenti sono 'rimediati' attraverso medium simbolici: nel nostro caso i medium sono la statua, la maschera, la corda, il pallone, le canzoni, le tante citazioni in pastiche. Funzionano da filtri della memoria: contengono, nascondono e mostrano la vergogna soltanto per interposto medium.
La nuova trasposizione di Memorie dal sottosuolo, di cui qui ci occupiamo, necessita dell'integrazione di un saggio basilare: Dostoevskij e il parricidio (1927), nota pubblicazione con cui Sigmund Freud rintraccia nell'autore russo un Io masochista e un Super-Io sadico che fanno la cerimonia dell'interpretare, a turno, la parte del padre morto, da morti, spinti da un inesauribile senso di colpa che è fonte del loro godimento: più la voce e gli atteggiamenti sono femminei e omoerotici, più cresce il piacere di sentirsi castrati. A questa pantomima a due, la regia di Colucci aggiunge il ruolo della pulsione di morte con il terzo personaggio freudiano, l'Es, che nel sottosuolo vuole uccidere il femminile interiore: così, la statua-Liza, la maschera da maiale-Igor e il corpo di Avallone sono i personaggi del triangolo edipico che ha, schizofrenicamente, polifonicamente, sempre la voce di Avallone, nelle tante identità che lui gioca. Questa lettura freudiana vedeva nelle opere (e nella persona) di Dostoevskij un sadomasochismo femmineo, nevrotico-epilettico, eccelso nello stile e totalmente inaffidabile e contraddittorio nell'ideologia religiosa e politica. Se con il finire del Novecento accademici come Joseph Frank hanno rifiutato l'interpretazione freudiana, ci sono oggi ancora studiosi, come Steven Rosen (2021), che ne sottolineano l'importanza per lo stesso approccio queer usato da Colucci e Avallone.
È proprio grazie a Freud che l'incontro artistico tra i due coautori può rendere sul palco la violenza che è già propria del testo di Memorie dal sottosuolo: il protagonista più volte vorrebbe soffocare Liza perché lui si sente soffocare. Non c'è nel testo di Dostoevskij la redenzione trionfale tipica del martire masochista che nel narcisismo evita l'angoscia di castrazione (Theodor Reik, 1941). Il protagonista affida proprio al finale disperato la definizione della sua condizione castrata di figlio morto nato da un padre morto: questo perché, come commenta Alberto Moravia (1975), il suo senso di colpa è inestirpabile. Come conferma Vittorio Strada (2018), Dostoevskij gode della stessa «catastrofe» di Nietzsche: nessuna idea interiore e nessuna cosa esteriore hanno senso, tanto meno il male e il bene: solo le sensazioni fisiche e il dolore hanno senso. Per questo, in Depravazione, la rabbia sadica non ha fine né limiti: così, Avallone compie davanti a noi le azioni di soffocare il manichino-Liza, sparare ripetutamente contro di esso, mettere sul "cadavere" di Liza la maschera del maiale e fare il gesto di urinarci sopra slacciandosi la cintura e ricomponendosi due volte davanti a noi così come per due volte fa le azioni del piangere lacrime vere e subito del deridere la tecnica del piangere appena usata. Infine, uscito dal personaggio di Dostoevskij, mentre ascoltiamo il Conphiteor di Piero Ciampi, Luca Avallone si congratula con gli altri due "attori", Veronique (la statua) e Igor (la maschera di maiale), dando l'idea che ora non esiste un fuori dal personaggio:anche l'attore, che rispetto a questo momento riferisce di subire l'identificazione, vive nel sottosuolo, nella nebbia, nella psicosi allucinatoria dell'indistinto. Così, come si era presentato all'inizio, quello che adesso è solo Luca («e loro sono gli altri») si mette la lunga corda al collo, gioca col pallone, indossa la maschera da maiale e, guardandoci, alza il pollice come Dale Cooper e dice: «Sono pronto». Sistema la scena dell'eterno confronto con la statua: sotto le luci rosse, siede di fronte a essa fissandola. Circolarmente torna la canzone che aveva aperto lo spettacolo: Adius. Dopo il verso di Ciampi «Ma non sono io, sono gli altri», Avallone si volta e, attraverso la maschera da maiale, ci guarda.
Articolo di Adriano Emi (Roma-Tre) discusso con Stefano Colucci e Luca Avallone il 21 novembre ad Avezzano